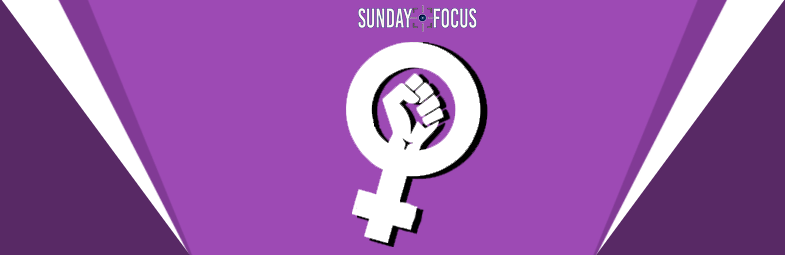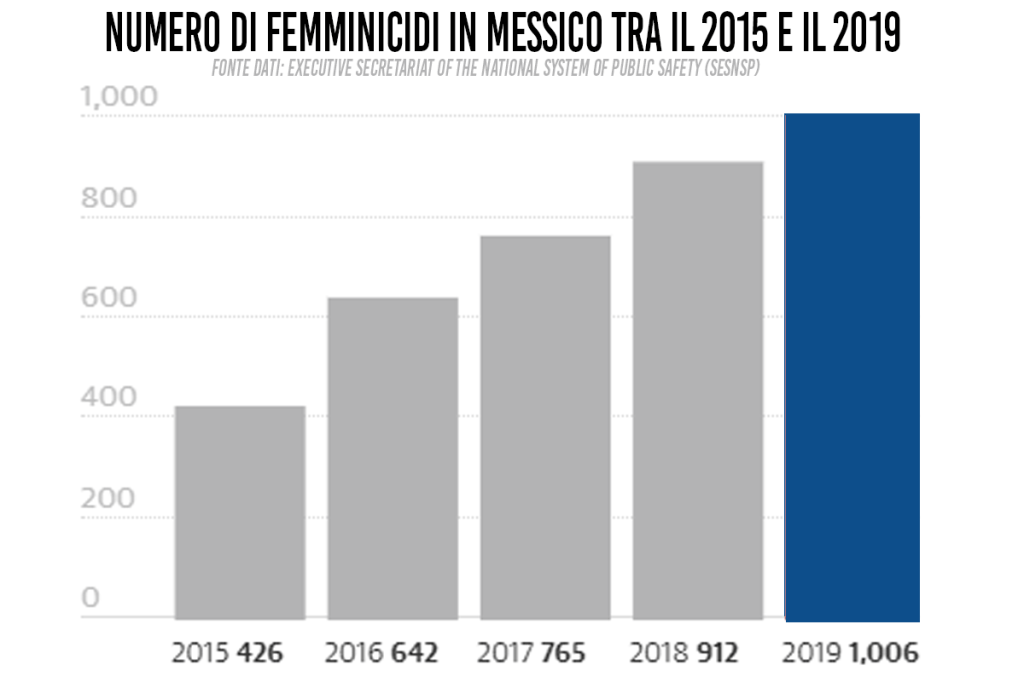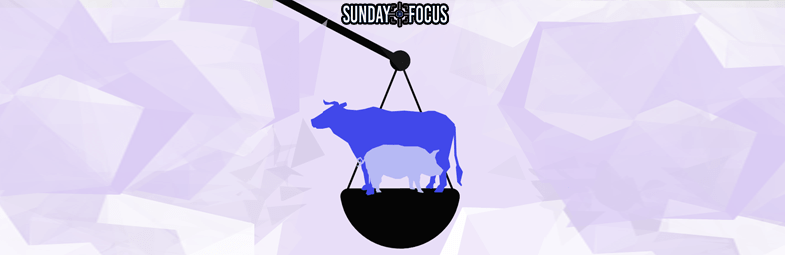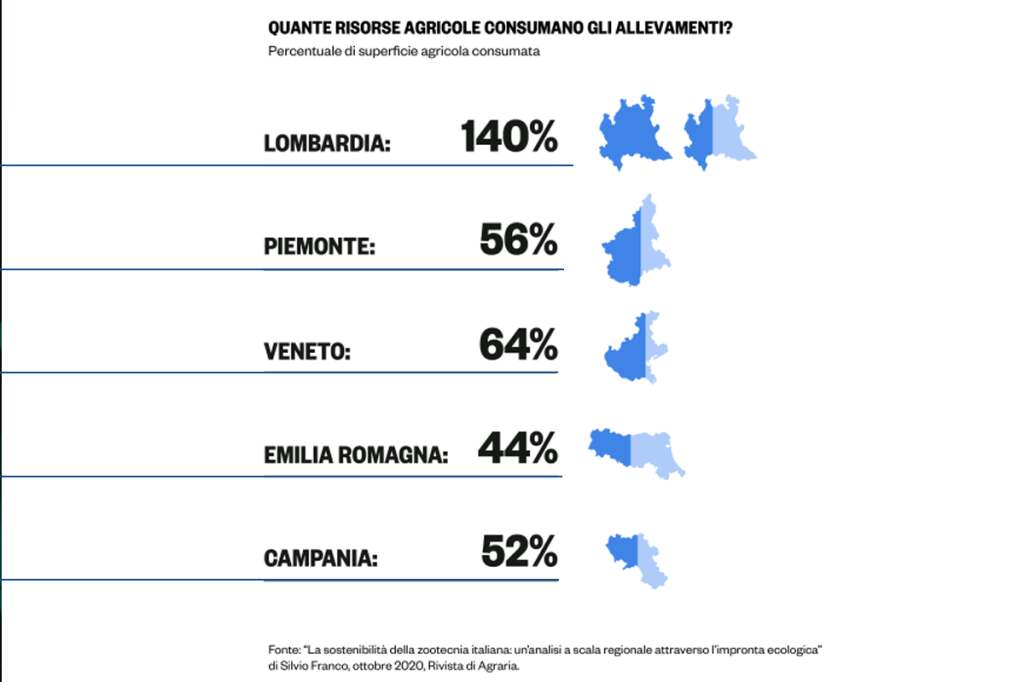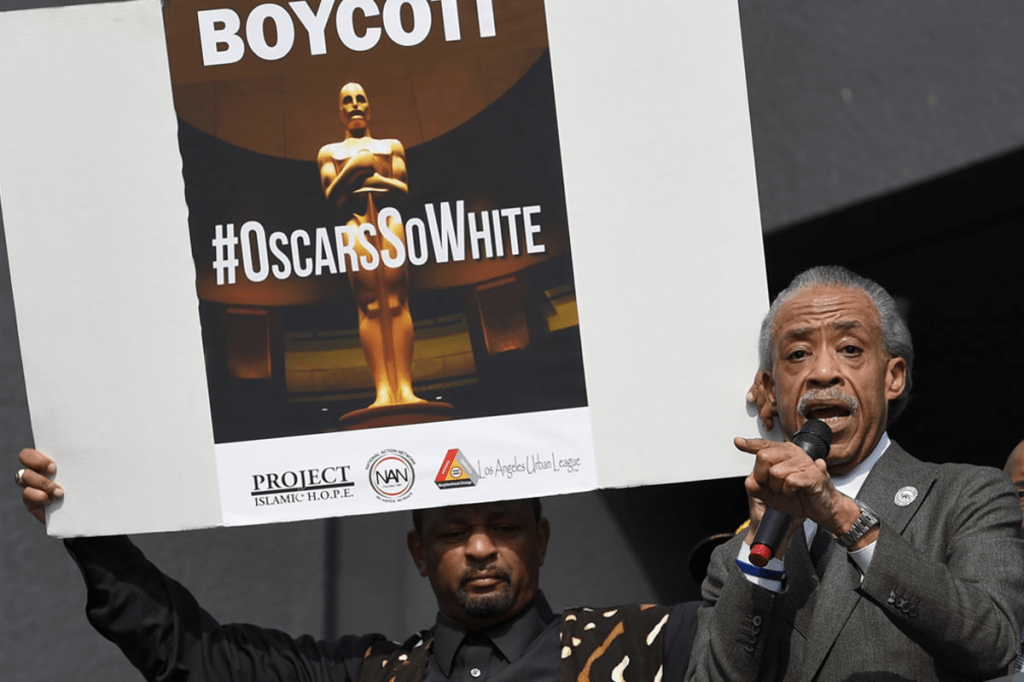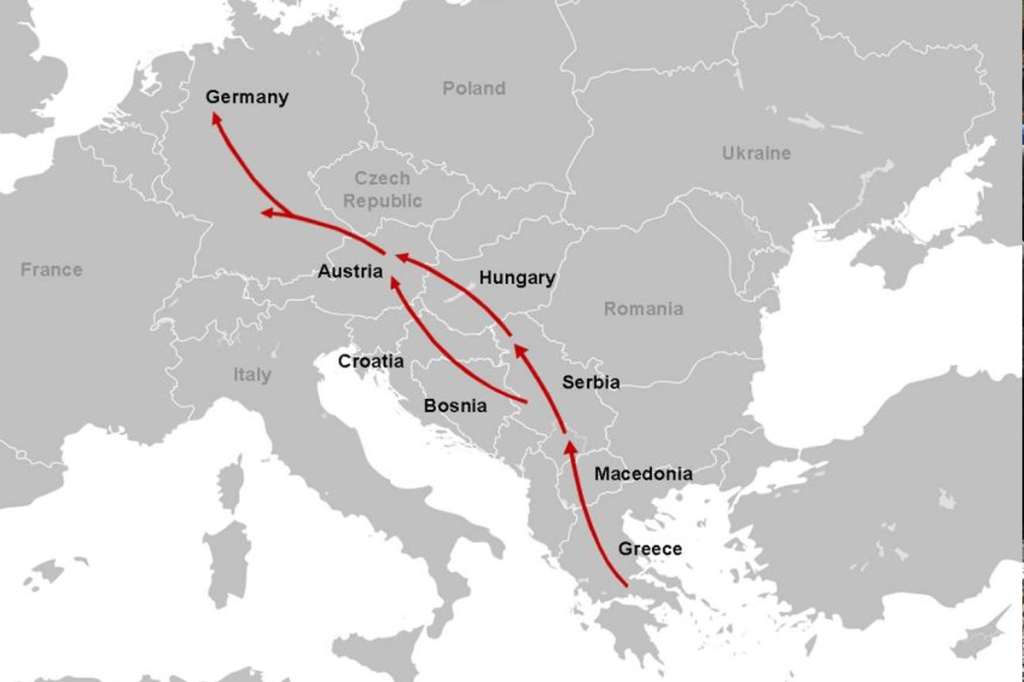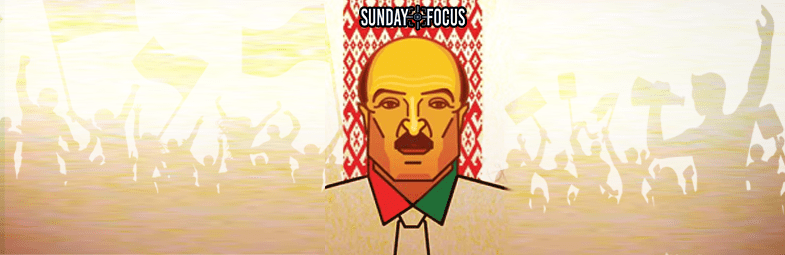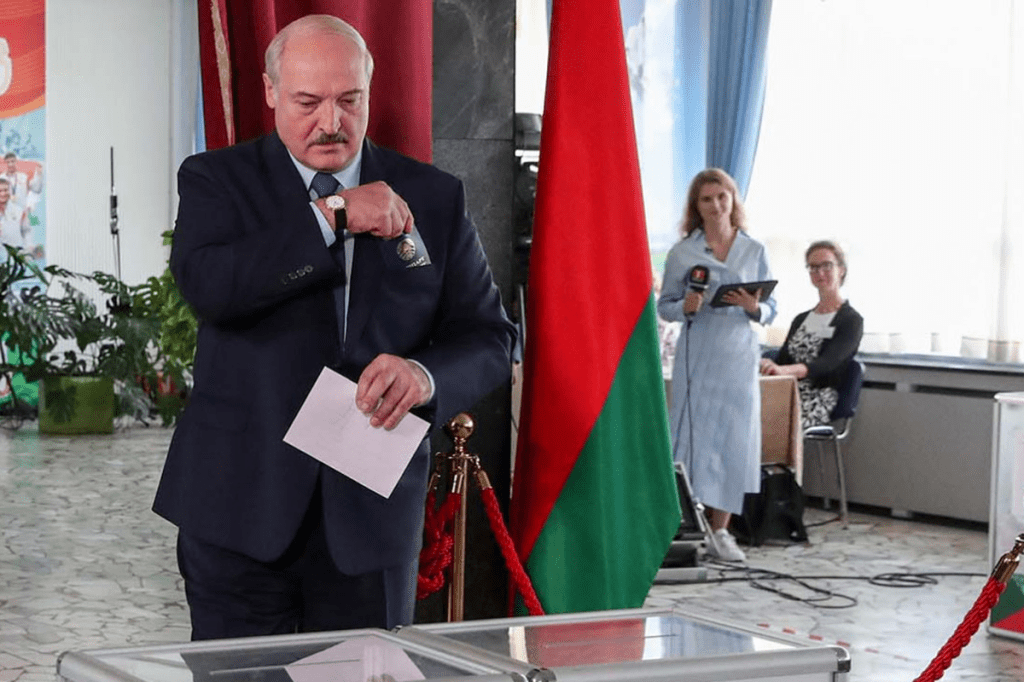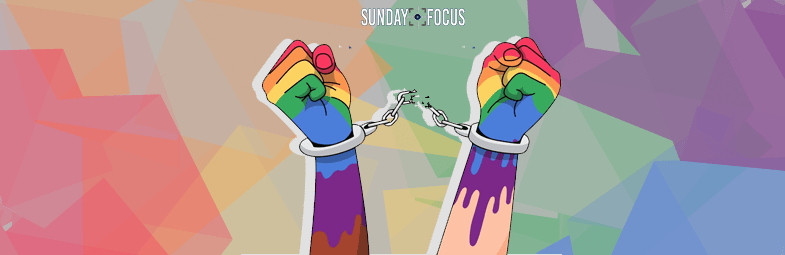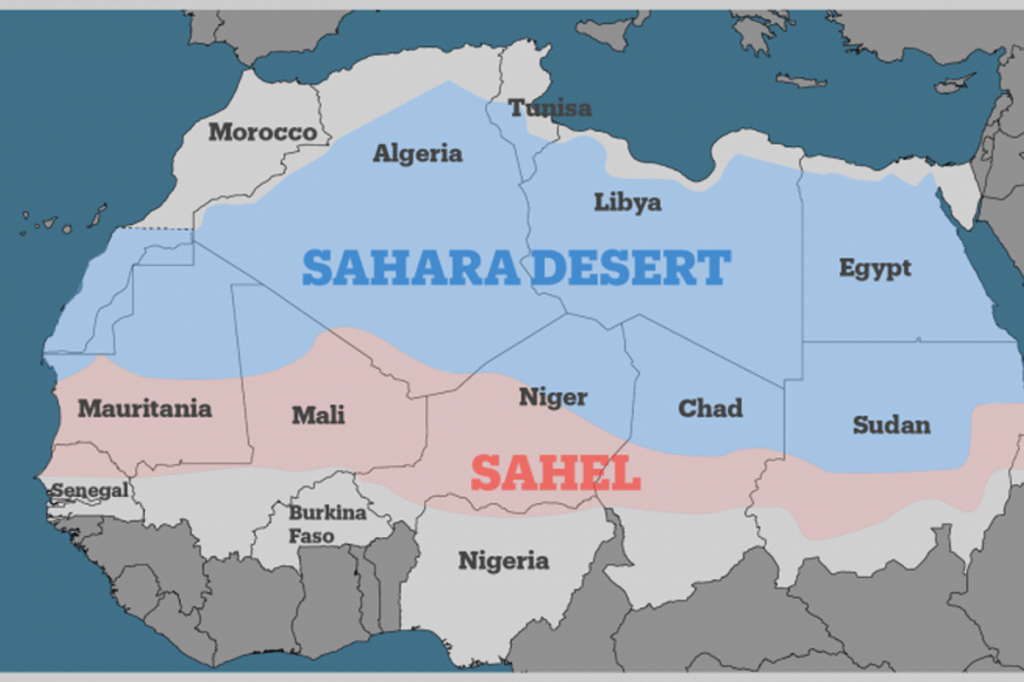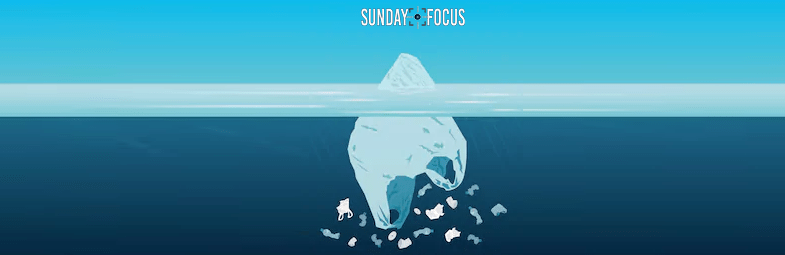Dalla concorrenza all’ambiente: i lati oscuri del Black Friday

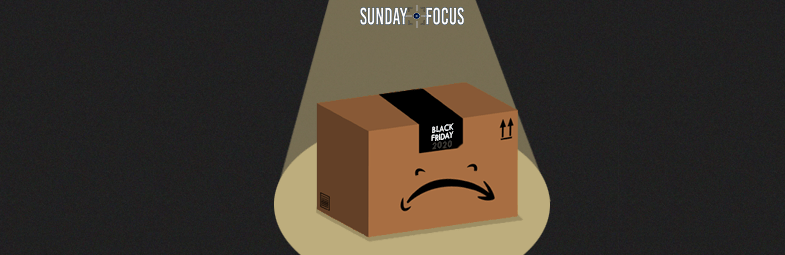
“La pubblicità ha spinto questa gente ad affannarsi per automobili e vestiti di cui non hanno bisogno.
Intere generazioni hanno svolto lavori che detestavano solo per
comperare cose di cui non hanno veramente bisogno”
-Fight Club-
Il quarto venerdì di novembre, quello successivo al giorno del ringraziamento americano, scatta l’ora X dello shopping. Anche quest’anno, nonostante la pandemia, il 27 novembre torna il “Black Friday” il giorno che tradizionalmente negli Stati Uniti dà il via alle spese natalizie. E proprio per dare il via nel migliore dei modi alle compere natalizie negozi fisici ed online propongono per quel giorno promozioni e offerte irresistibili. Un fenomeno sempre più diffuso tanto che lo scorso anno negli Stati Uniti si sono registrati dati da record: 168 dollari di spesa media, in crescita di circa il 6%, e vendite che nel complesso hanno registrato 6,22 miliardi di dollari di incassi, con un aumento del 23,6% rispetto al Black Friday del 2018. Quest’anno, però, complice la pandemia il “Black Friday” rischia di trasformarsi in un vero e proprio venerdì nero del commercio e non solo.
E-commerce – La grande protagonista di questo giorno è da ormai alcuni anni Amazon, la piattaforma di e-commerce più utilizzata al mondo. Lo scorso anno durante la sola giornata del Black Friday nel nostro paese sono stati effettuati in media 37 acquisti al secondo su Amazon, una cifra da record che rispecchia una tendenza complessiva che vede una crescita esponenziale dell’e-commerce rispetto ai negozi fisici. Una crescita che quest’anno potrebbe essere ancora maggiore considerando che a causa dell’emergenza sanitaria e delle restrizioni imposte molti negozi non potranno nemmeno alzare le saracinesche perdendo così un’importante occasione di guadagno e di rilancio di attività già piegate dalla crisi.

Per il Codacons saranno 25 milioni gli italiani che approfitteranno di sconti e promozioni del Black Friday per fare almeno un acquisto con un aumento del 47% rispetto allo scorso anno. L’intera settimana genererà nel 2020 un giro d’affari di oltre 2,5 miliardi di euro, con una crescita del +27% rispetto al 2019. Ma questa volta non dobbiamo aspettarci nessuna calca nei negozi di elettronica né code fuori dai principali marchi di abbigliamento: il Black Friday rischia di rimanere solo sul web. Proprio da qui nasce il primo problema legato a questa giornata: la concorrenza. Come evidenziato da Confesercenti, con la chiusura dei negozi fisici “il canale delle vendite web di fatto agisce ed opera in condizioni di monopolio”. Se lo scorso anno si stima che in Italia le vendite nei negozi siano aumentate del 23% durante l’ultima settimana di novembre, quest’anno potrebbe non esserci alcuna crescita con evidenti ricadute su interi settori. Con la chiusura di oltre 190mila attività commerciali nelle regioni in zona rossa e di altre 68mila in zona arancione, secondo le stime saranno circa 700 i milioni che gli italiani spenderanno sul web invece che nei negozi durante la giornata di venerdì. Una cifra significativa a cui vanno aggiunti da qui a Natale “ulteriori 3,5 miliardi di euro di spesa dei consumatori per i regali e per l’acquisto di beni per la casa e la famiglia”. Per molti esercenti le chiusure nel periodo in cui crescono esponenzialmente le spese degli italiani potrebbe rappresentare il colpo di grazia in un anno segnato da una profonda crisi economica.
Per far fronte a questa situazione, in Francia è stato raggiunto un accordo tra le piattaforme digitali, con Amazon in prima fila, e i rappresentanti dei commercianti per rimandare il Black Friday. Per dare la possibilità ai negozianti di aprire le proprie attività dopo le restrizioni e garantire così il rispetto della concorrenza le promozioni verranno rimandate da una settimana. Un modo per sostenere gli esercenti francesi, ha sottolineato l’amministratore delegato di Amazon Francia Frederic Duval, e permettere loro di rialzarsi dopo le pesanti perdite di quest’anno.
Ambiente – Ma se la soluzione francese può essere utile per limitare la crisi dei negozi fisici, l’aumento delle vendite via web comporta un enorme pericolo per l’ambiente difficilmente contrastabile in questo modo. Quello che preoccupa è infatti quanto la corsa agli acquisti produrrà in termini di inquinamento e di emissioni di gas serra. Non solo per la produzione degli oggetti che saranno posti sugli scaffali virtuali dei venditori on line, ma soprattutto per la distribuzione e la consegna degli articoli acquistati. Se già da tempo era stato fatto notare da più parti come l’acquisto di prodotti via web contribuisca in modo significativo all’aumento delle emissioni, ora una ricerca condotta da “Money” in Gran Bretagna da un’idea più precisa di quanto potrebbe accadere.

Gli esperti hanno analizzato la quantità di CO2 che verrà prodotta dalla consegna dei pacchi agli acquirenti britannici prendendo in considerazione le credenziali ambientali delle aziende di consegna, il numero di pacchi che si prevede saranno portati a casa degli acquirenti e le emissioni di anidride carbonica prodotta da ciascuna consegna. Una ricerca che, come sottolineano gli stessi autori, pur essendo stata condotta in Gran Bretagna può essere valida per quasi tutti i paesi occidentali, Italia compresa. I dati che emergono, però, lasciano senza parole: a fronte di un aumento delle vendite on line che dovrebbe aggirarsi, nel solo Regno Unito, attorno ad un + 14% rispetto al 2019, le emissioni di CO2 previste per il Black Friday di quest’anno in Gran Bretagna, saranno superiori alle 429 mila tonnellate. Per vere un’idea di quanto il dato sia pesante, spiegano gli stessi ricercatori inglesi, è la quantità di emissioni che si avrebbe con 435 voli di andata e ritorno dall’Unione Europea a New York. A peggiorare le cose, poi, c’è l’aspettativa dei clienti di avere le consegne nel minor tempo possibile: quelle in giornata, ad esempio, imporranno alle aziende di trasporto di incrementare la flotta dei veicoli in circolazione, sia pure temporaneamente, con un sensibile aumento delle emissioni di anidride carbonica.
Secondo una ricerca pubblicata nel 2017 da Brian & Company, l’e-commerce risulta essere maggiormente dannoso per l’ambiente per tre motivi: la tendenza degli acquirenti ad ordinare piccole quantità per volta; effettuare ordini multipli di merce che richiedono più viaggi a causa della localizzazione dei fornitori o dei clienti; aumento di imballaggi aggiuntivi e non riciclabili. In Italia, per esempio, l’e-commerce consuma mediamente il 35% di tutta la plastica prodotta nel nostro Paese.
Se dunque per rilanciare i piccoli negozi può essere utile spostare il Black Friday dopo le chiusure, per l’ambiente è necessaria una maggior sensibilità da parte degli acquirenti. Gli sforzi fatti dalle principali piattaforme di e-commerce per limitare le emissioni sono infatti vicini allo zero e anche la recente istituzione di un fondo da 10 miliardi che il fondatore di Amazon Jeff Bezos intende destinare ad associazioni e organizzazioni che combattono il cambiamento climatico sembra essere più un tentativo di “greenwashing” che una reale presa di coscienza del problema. Ancora una volta la risposta a questo problema sembra arrivare dalla Francia dove associazioni e commercianti hanno lanciato la campagna #NoelSansAmazon (Natale senza Amazon) chiedendo ai francesi di acquistare i propri regali nei negozi e non sul web. La comodità di acquistare dalle piattaforme di e-commerce è senza dubbio evidente ma i costi collaterali, come visto, sono altissimi e li paghiamo tutti. Viene dunque da chiedersi: vale davvero la pena pagare così tanto per un briciolo di comodità in più?