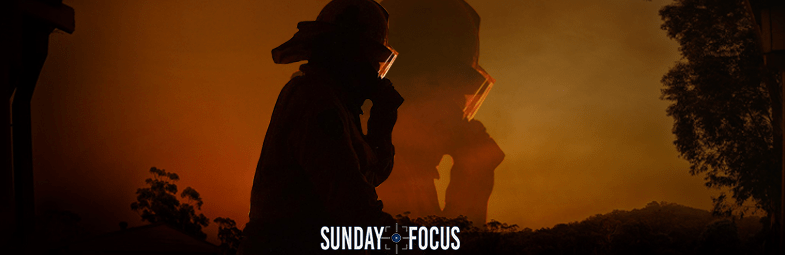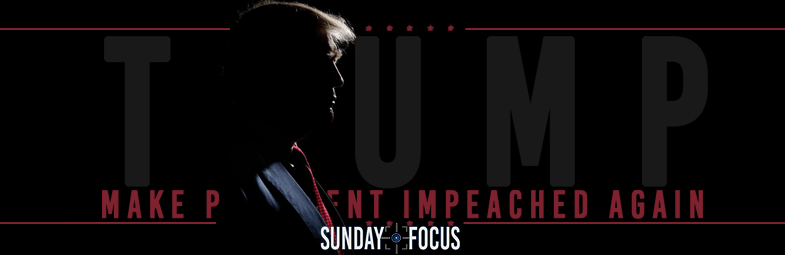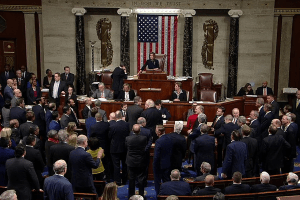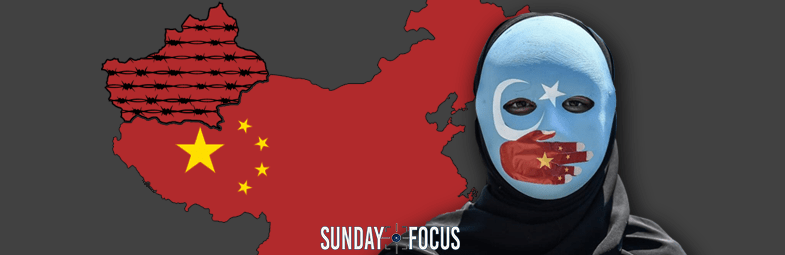Perchè piangiamo Kobe Bryant


“Whether you view me as a hero or a villain,please know I poured every emotion,every bit of passion and my entire self.”
“Sia che mi vediate come un eroe o come il cattivo,per favore, sappiate che ci ho messo ogni emozioneogni briciolo di passione, tutto me stesso.”
-Kobe Bryant, Lettera ai tifosi-
Un silenzio irreale. Un violoncello in mezzo al campo suona l’Hallelujah mentre sul tabellone scorrono le immagini di una carriera indimenticabile. Sugli spalti lacrime, commozione ed un silenzio che allo Staples Center di Los Angeles probabilmente non si sente nemmeno quando è vuoto. È il grande omaggio del popolo gialloviola ad un giocatore che per i Lakers, e per tutto il basket, ha significato molto più di quello che si può immaginare. Il prepartita è tutto per lui. Fuori dallo Staples Center migliaia di persone si sono radunate per portare fiori e ricordi. Sugli spalti ventimila maglie con i numeri 24 e 8 e due posti vuoti. Per Kobe Bryant e Gianna Bryant.
Kobe – Nato a Philadelphia il 23 agosto 1978, Kobe ha iniziato a giocare a basket all’età di 3 anni e non ha mai smesso. Figlio di Joe Bryant, ex cestista nel nostro campionato, Kobe ha vissuto per 7 anni in Italia seguendo il padre nelle sue avventure sportive tra Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. L’amore tra Kobe e il nostro paese è rimasto immutato in lui per tutta la vita, conquistato de un Italia così diversa dagli USA ma così bella e calorosa. E proprio quell’amore per l’Italia lo stava per portare a giocare nel nostro campionato. Nel 2011 in NBA scatta il “lockout”, lo sciopero delle proprietà delle squadre della lega che blocca totalmente il basket americano: le squadre non possono operare sul mercato, non si possono organizzare amichevoli, esibizioni o summer camp, i giocatori non ricevono gli stipendi e non possono avere nessun tipo di rapporto con i loro club. Una situazione che porta molti giocatori a scegliere, per qualche mese, di giocare in Europa per non perdere l’allenamento. Nasce li la pazza idea della Virtus Bologna di portare Kobe in Italia: dieci partite per un ingaggio totale di 3 milioni di euro, tra il 9 ottobre e il 16 novembre 2011. Kobe ci pensa, si confronta con il suo procuratore, e alla fine accetta. Nemmeno il tempo dei titoloni sui giornali, “Kobe quasi sì a Bologna” scrisse la Gazzetta, e arrivò il ripensamento. La NBA sarebbe potuta ricominciare da un momento all’altro e il Mamba non voleva rischiare di perdere un mese di regular season per il contratto con Bologna. Kobe scelse quell’NBA che lo aveva reso leggenda.
E in NBA Kobe ha lasciato un segno indelebile. Con 33.643 punti è il quarto miglior marcatore della storia della lega superato al terzo posto, con uno strano scherzo del destino, da LeBron James la sera prima dell’incidente proprio in quella Philadelphia che gli diede i natali. In carriera ha avuto una media di 25 punti a partita, da aggiungere a uno score di 4,7 assist, 5,3 rimbalzi e un totale di oltre 1.800 palle rubate. In carriera è stato due volte MVP delle Finals NBA, ha vinto due ori olimpici, cinque titoli NBA e anche un Oscar per il miglior cortometraggio. Dal 13 novembre 1996, Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves (0 punti), al 13 aprile 2016, Los Angeles Lakers – Utah Jazz (60 punti). 20 anni con la stessa maglia, 1346 partite con la canotta gialloviola e quei due numeri: l’8 fino al 2006 “per piantare la sua bandierina nella lega” poi il 24 “simbolo della crescita: gli attributi fisici non sono quelli di una volta, ma la maturità e aumentata”. Due numeri che oggi tutto il mondo omaggia in ogni modo possibile. Due numeri che ora sono indissolubilmente legati ad un nome: Kobe Bean Bryant.
Leggenda – La morte di Kobe lascia increduli e storditi. Non solo per il modo in cui è arrivata, e non entreremo nel merito della vicenda e del dibattito sulla scelta di volare in condizioni non ideali, ma anche e soprattutto perché inaspettata e imprevedibile. Inaspettata ed imprevedibile come erano le sue giocate. Inaspettata e imprevedibile e dunque ancora più dolorosa. Il mondo del basket e quello sportivo più in generale hanno pianto la scomparsa di un campione che ha saputo travalicare i confini del suo sport diventando icona. Pochi prima di lui ci sono riusciti. Pochi riusciranno a farlo dopo di lui.

Perché Kobe ha rappresentato per un’intera generazione, quella nata tra gli anni ’80 e i ’90, il punto di riferimento nel mondo del basket. In un basket che sembrava potesse sprofondare nel buio dopo il ritiro di Michael Jordan, Kobe ha riacceso la luce prendendosi la scena e diventando per quella generazione ciò che Jordan fu per la precedente. Kobe era quel giocatore che conosceva anche chi non seguiva il basket. Era quel giocatore di cui tutti i ragazzini al campetto avevano la canotta e imitavano le mosse. Per 20 anni Kobe ha rappresentato l’atleta individualista per eccezione, un maestoso solista capace di fare canestro quando voleva e come voleva, a prescindere dal difensore, dal compagno, dall’allenatore in panchina o dai fischi dei tifosi in tribuna. Per 20 anni Kobe è stato anche un meraviglioso direttore d’orchestra in grado di smistare palloni d’oro ai compagni, la coppia Bryant-O’Neal è nella storia della pallacanestro, e di motivarli all’inverosimile prima e durante le partite. Kobe è riuscito ad essere contemporaneamente icona individuale e uomo squadra perfetto. Ci ha insegnato che non importa quanto si può essere forti, non si è mai migliori degli altri e si può vincere solo facendolo tutti insieme. Con i suoi allenamenti notturni mentre tutti dormivano, con i suoi tiri in solitaria alle 5 del mattino in una palestra deserta, con la sua “mamba mentality” ci ha insegnato che si può sempre migliorare, anche dopo 5 titoli NBA. Basta crederci e dare tutto. Kobe ha reso reale quello che tutti pensavamo potesse esistere solo nella nostra immaginazione. Perché tutti noi abbiamo iniziato da quei calzini arrotolati lanciati nel cestino, come in quel cortometraggio da Oscar. Perché se nel silenzio di un campetto di periferia, mentre la palla lasciava le mani, abbiamo sentito la sirena di fine quarto e il boato dello Staples Center è stato solo grazie a lui. Perché se quando tiriamo, gridiamo ancora “Kobe!” scoprendoci campioni quando la palla danza sul ferro è grazie a lui. Da NBA Action di Italia1 alla pay-tv passando per Sportitalia e i siti pirata con telecronaca in russo. Quella sveglia puntata alle 2 o alle 3 di notte era dolcissima. Per vent’anni le nostre notti insonni hanno avuto lui come attore protagonista, le sue movenze, i suoi arresto e tiro, i suoi sorrisi. Per vent’anni lo abbiamo visto danzare su un parquet con la palla in mano. Lo abbiamo visto cadere, piangere e rialzarsi più forte. Lo abbiamo visto vincere e lo abbiamo visto perdere. Per vent’anni Kobe è stato il basket. E forse no, non siamo pronti a lasciarlo andare. E ora che non c’è più, chiudendo gli occhi immagino ancora quel cronometro che scorre. Cinque secondi alla fine, palla in mano. Quella danza sulla linea dei tre punti, e un finale che già si sa.
“5… 4… 3… 2… 1…Love you always.”