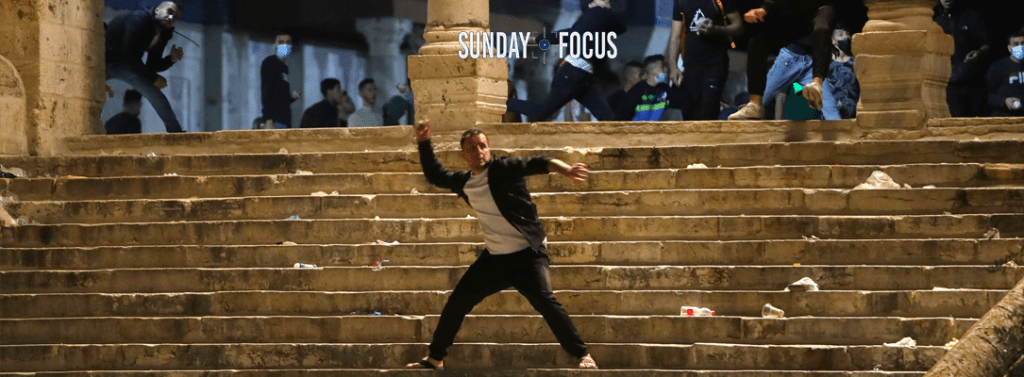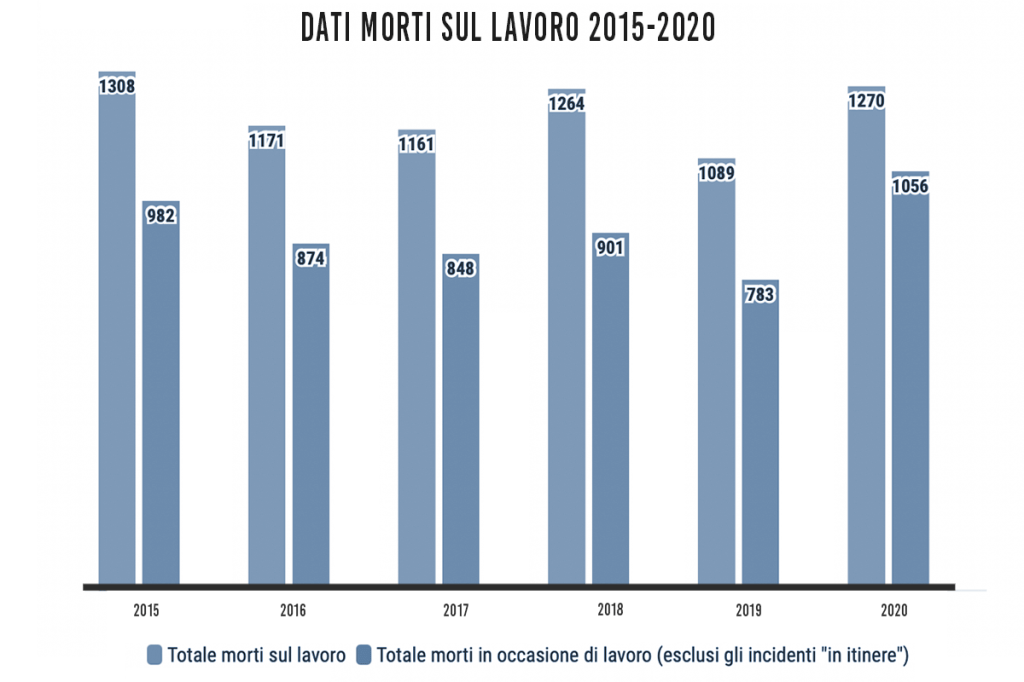Gli UFO esistono: la storica svolta dietro l’ammissione del Pentagono


Extraterrestre portami via
Voglio una stella che sia tutta mia
Extraterrestre vienimi a pigliare
Voglio un pianeta su cui ricominciare
-Eugenio Finardi-
“Esistono oggetti volanti non identificati. Non sappiamo cosa siano né come facciano a volare in quel modo e a seguire quelle traiettorie. È necessario approfondire con indagini e ricerche”. Una dichiarazione che lascerebbe un po’ il tempo che trova se a farla non fosse l’ex Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, certo non un fanatico degli avvistamenti alieni. Non una battuta, ma una frase detta con serietà istituzionale. Le dichiarazioni di Obama, arrivate durante un’intervista alla CNN, ricalcano le modalità con cui tutti i principali media americani in questi giorni stanno trattando l’argomento. Perché, a 69 anni dai “caroselli di Washington”, l’attenzione sugli UFO è tornata ai massimi livelli negli Stati Uniti.

L’avvistamento – Tutto è iniziato nei primi giorni di questa settimana quando la portavoce del Pentagono, Susan Gough, ha spiazzato tutti con una dichiarazione che conferma la veridicità di un video girato nel 2019 in cui si vede un oggetto non identificato volare a mezzaria prima di scendere in picchiata e immergersi in mare. Per anni, dopo la pubblicazione di quel video, molti appassionati hanno dibattuto sulla possibilità che si trattasse realmente di un UFO, tanto che la task force che all’interno del Dipartimento alla difesa si occupa dei fenomeni aerei non identificati aveva avviato un’indagine. Il video, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, mostra quello che gli esperti del Pentagono hanno definito “transmedium veichle”, un veicolo cioè in grado di muoversi in aria, in acqua e nel vuoto e che, come si vede dalle immagini, è entrato nelle acque dell’Oceano senza subire alcun danno. Proprio a conclusione della prima parte dell’indagine la Gough ha informato il mondo del suo esito: “Posso confermare che il video è stato effettivamente girato dal personale della Marina e che sulle immagini sono ancora in corso delle indagini”. Una dichiarazione che, da sola, ha fatto riaccendere un dibattito mai realmente sopito sull’esistenza di oggetti volanti non identificati.
Il rapporto – A conferma di quanto l’interesse per la materia non sia più solo appannaggio di complottisti o fanatici degli alieni, vi è l’attenzione sempre crescente che il governo americano sta mettendo nello studio e nel contrasto del fenomeno. E se da una parte ormai le autorità non negano o smentiscono più di aver raccolto materiale sul fenomeno, dall’altra la questione diventa sempre più politica, con le parole dei senatori Marco Rubio che vede negli UFO, o UAP come vengono definiti ora, una “minaccia alla sicurezza nazionale” e il democratico Martin Heinrich che parla apertamente degli Uap come “tecnologia troppo sofisticata per essere umana”. Così, mentre in Europa la tendenza è di ridurre il dibattito sul tema al classico “gli alieni non esistono è inutile parlarne”, negli Stati Uniti la vicenda si fa sempre più seria. Dopo aver desecretato, un anno fa, i video di decine di avvistamenti ad opera di mezzi militari statunitensi, il Pentagono si prepara a pubblicare un ricco dossier realizzato dalla Unidentified Aerial Phenomena Task Force, la divisione dell’intelligence americana che si occupa di UFO. Un rapporto, richiesto dal senatore Marco Rubio, che fa già tremare l’intelligence americana non solo perché dovrebbe rivelare i frutti di uno studio approfondito del fenomeno, ma anche perché, secondo molte fonti, metterebbe in luce alcuni dei più grandi fallimenti dell’intelligence dall’11 settembre ad oggi. Tutti, ovviamente, in materia di oggetti volanti non identificati. A giugno quel dossier sarà pubblico e, forse, si saprà qualcosa in più sull’esistenza e sulla natura dei misteriosi avvistamenti.
Il nuovo atteggiamento delle autorità sull’argomento, però, rappresenta già di per se un fatto degno di nota. La desecretazione di immagini e video dello scorso anno, le dichiarazioni di questi giorni e la prossima pubblicazione di un dossier governativo hanno di fatto per la prima volta nella storia spostato il focus. Ora, infatti, quando si parla di Ufo la questione non è più la loro esistenza ma la loro natura. Si tratta, come comprensibile di una svolta epocale. L’esistenza di oggetti volanti identificati, oggi, non è più negata ma viene data per assodata anche dal governo degli Stati Uniti. Il tutto mentre Louis Elizondo, ex agente Cia e responsabile dell’AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program), dichiara pubblicamente che il governo americano è in possesso di “reperti” recuperati nei luoghi di presunti Ufo crash, da relitti degli oggetti volanti. Insomma gli Usa avrebbero parti e componenti degli Uap, custoditi in luoghi non noti.

Da Roswell a Washington – D’altronde, che gli Stati Uniti siano in possesso di reperti del genere è uno dei temi che da sempre affascina il mondo intero. Un tema nato per la prima volta quando si verificò il cosiddetto “incidente di Roswell” del 2 luglio 1947 quando un oggetto non identificato precipitò al suolo. La vicenda divenne presto famosa in quanto le prime notizie divulgate dai giornali ipotizzarono che si fosse verificato lo schianto di uno o più UFO al quale, secondo alcune teorie, sarebbe seguito il presunto recupero di cadaveri di extraterrestri da parte dei militari statunitensi ed il successivo trasporto nella misteriosa “Area51”. Le dichiarazioni ufficiali, che parlarono di un pallone sonda schiantatosi al suolo, non convinsero mai gli scettici e da quel momento nacque il mito degli Ufo e di una base militare segreta per il loro studio. Da quel momento si sono registrate centinaia di avvistamenti alcuni smentiti, altri mai chiariti. Il più noto, e misterioso, rimane però il cosiddetto “carosello di Washington” del 1952 quando per diversi weekend i cieli off limits sopra il campidoglio furono illuminati da luci bianche che volteggiavano sopra la città. Oggetti non identificati visti sia dai cittadini sia dai militari sui propri radar tanto che in breve tempo le basi aeree intorno alla capitale vennero allarmate e diversi caccia militari si alzarono in volo. Un volo inutile, però, perché pochi secondi prima che arrivassero nell’area dell’avvistamento gli oggetti non identificati sparirono nel nulla per ricomparire pochi minuti dopo il rientro alla base degli aerei.
Probabilmente non sapremo mai con certezza cosa fossero quelle luci. Non sapremo di preciso cosa cadde a Rosewell nel 1947 e nemmeno se effettivamente, nel deserto del Nevada, esiste una base militare adibita allo studio e alla catalogazione di reperti di questo genere. Ma oggi, per la prima volta nella storia, esiste una certezza: gli UFO esistono.