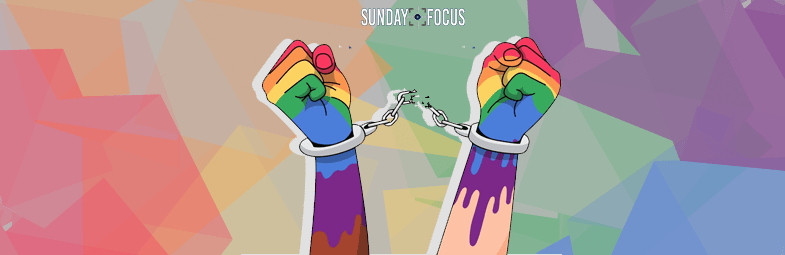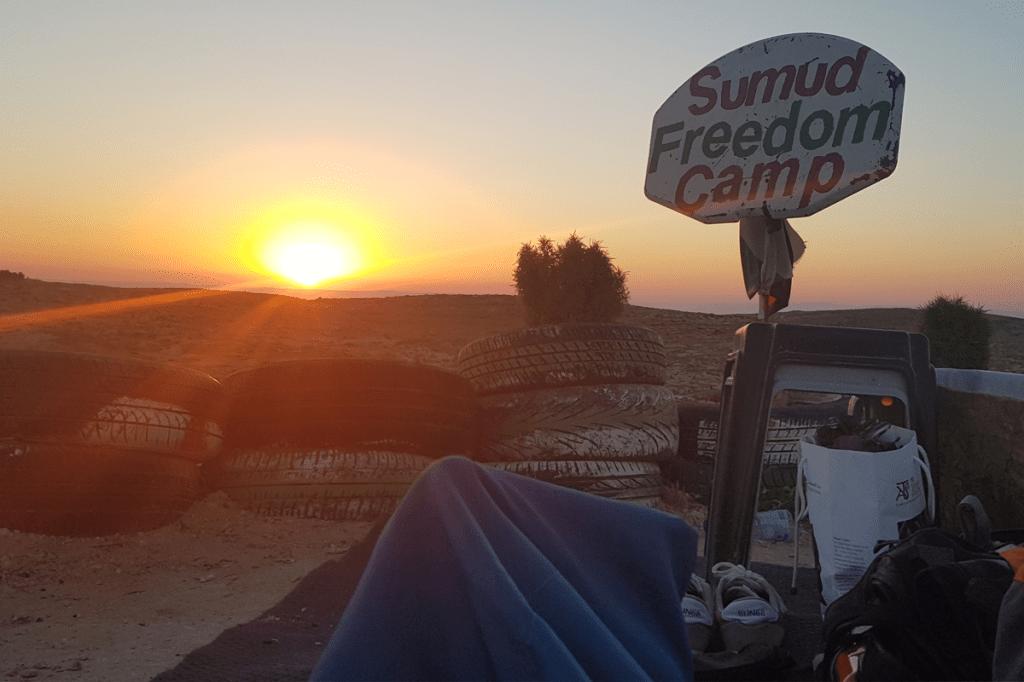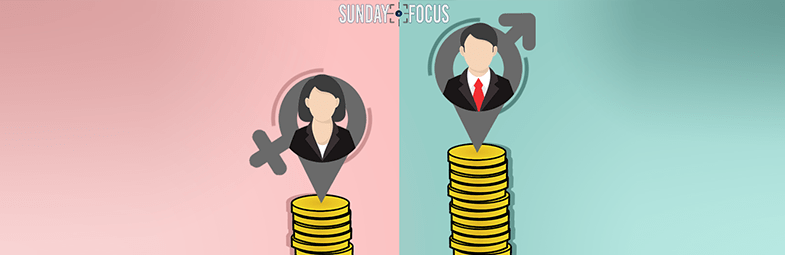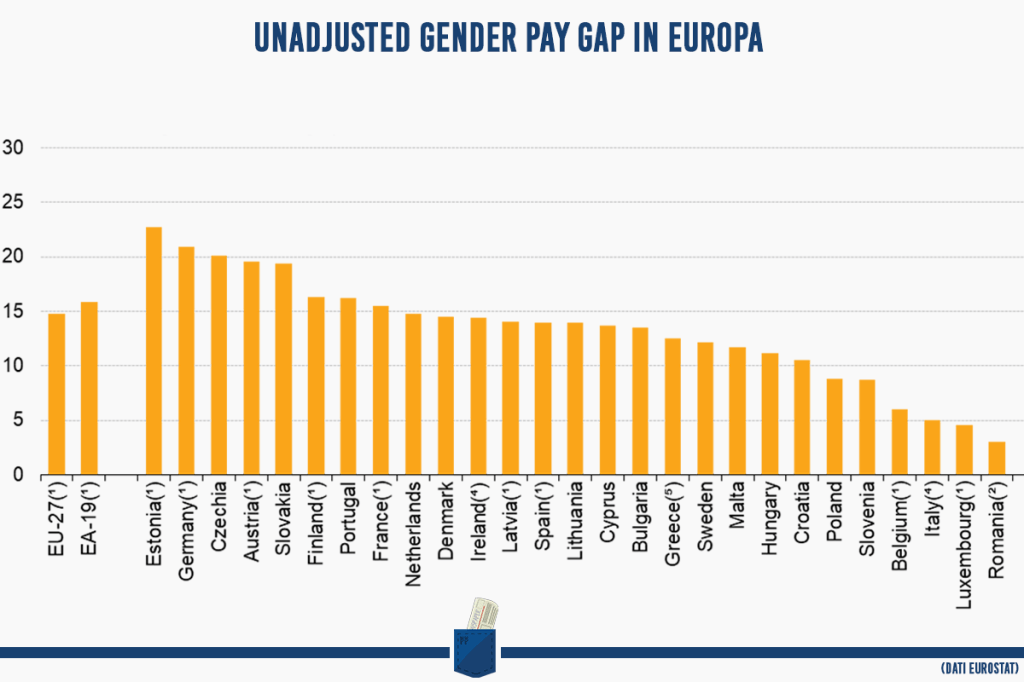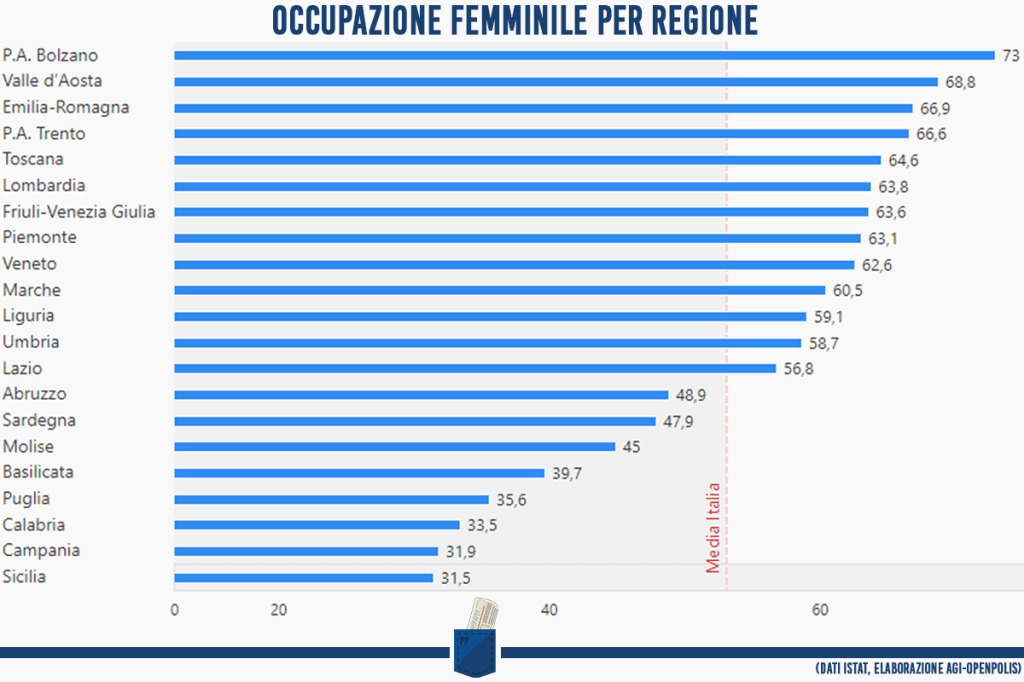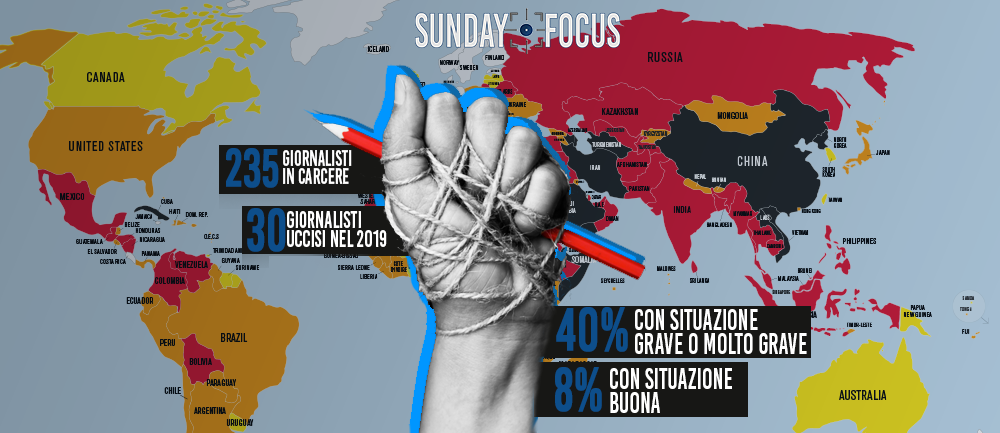Accesso gratuito a terapie ormonali per il cambio di sesso: chi può richiederlo e quali problemi ci sono

Con due Determine della Gazzetta Ufficiale viene per la prima volta riconosciuta in Italia la gratuità delle terapie ormonali per le persone transgender. Un passo in avanti fondamentale per il nostro paese che però presenta già alcune incrinature non di poco conto.

Mercoledì, la giunta regionale dell’Emilia-Romagna aveva votato una delibera che rende gratuito l’accesso su tutto il territorio regionale alla terapia ormonale per persone transgender. Sembrava essere l’ennesima conquista di una regione avamposto dei diritti umani e civili ma in pochi si potevano aspettare che sarebbe stato solo l’inizio di una vera e propria rivoluzione nazionale. Da oggi, infatti, l’accesso alla terapia ormonale per persone transgender è a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dunque gratuito in tutta Italia. Con due diverse Determine comparse in “Gazzetta Ufficiale” e datate 23 settembre, infatti, viene prevista per la prima volta la somministrazione gratuita di “testosterone, testosterone undecanoato, testosterone entantato, esteri del testosterone per l’impiego nel processo di virilizzazione di uomini transgender” e di “estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone acetato, spironolattone, leuprolide acetato e triptorelina per l’impiego nel processo di femminilizzazione di donne transgender”.
Una svolta importante, e per certi versi inattesa, che rafforza e dà piena attuazione ai principi di uguaglianza e rispetto delle persone senza discriminazioni di genere. L’accesso gratuito ai farmaci a base di testosterone ed estradiolo, necessari per la terapia ormonale, sarà dunque garantito ai soggetti che ne faranno richiesta dopo un consulto medico. Come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, infatti, l’accesso alla terapia sarà consentito solamente dopo una “diagnosi di disforia di genere/incongruenza di genere formulata da una equipe multidisciplinare e specialistica dedicata”. La diagnosi sarà effettuata sulla base delle linee guida diramate dall’OMS e condotta da un team di professionisti “con comprovata esperienza nel supporto delle persone con disforia/incongruenza di genere”. Con un responso positivo sarà dunque possibile accedere gratuitamente alla terapia firmando un modulo di consenso al trattamento. Unica eccezione sarà fatta in caso di incompatibilità tra la somministrazione degli ormoni e problemi di salute pregressi. Se in base ad un’attenta anamnesi dovessero emergere patologie che combinate con la terapia ormonale potrebbero arrecare gravi danni al paziente (ad esempio gravi insufficienze renali, alterazioni dei processi coagulativi o carcinomi mammari) l’accesso potrà essere negato.
L’ok ufficiale alla gratuità della terapia ormonale fa fare un balzo in avanti epocale per la normativa italiana che sul tema era ancora fortemente ancorata al cambio di sesso tramite chirurgia. Fino ad oggi la gratuità di tale trattamento era decisa a livello locale da province e regioni ma erano ancora poche quelle in cui era garantita. Con la nuova normativa si punta invece a mettere un punto alla questione rendendo la situazione uniforme in tutto il territorio nazionale. Un’uniformità che però sarà solo apparente e che già rischia di presentare alcune incrinature: per le persone transgender l’accesso alle terapie di transizione farmacologica continuerà ad essere variabile da regione a regione. Allo stato attuale, infatti, molte regioni sono sprovviste di centri specialistici riconosciuti dal ministero in grado di diagnosticare la disforia di genere. Un’assenza pesante che costringerà molte persone a spostarsi in una regione diversa da quella di residenza per vedersi garantito un diritto o, nel caso più estremo, di doverci rinunciare.