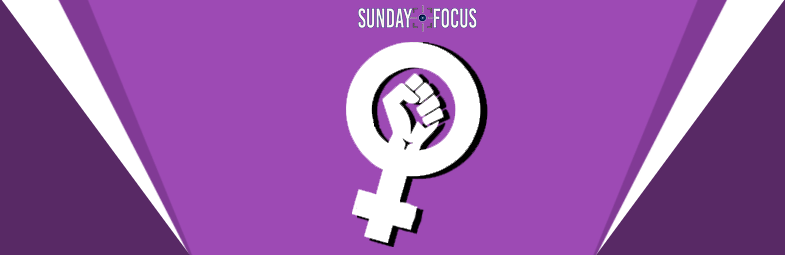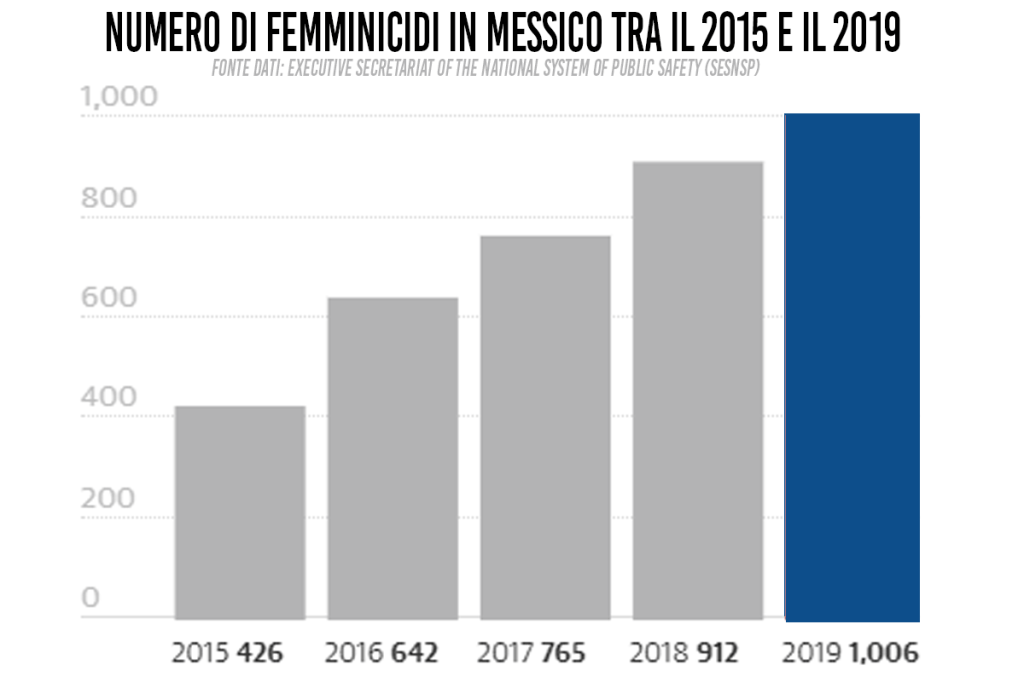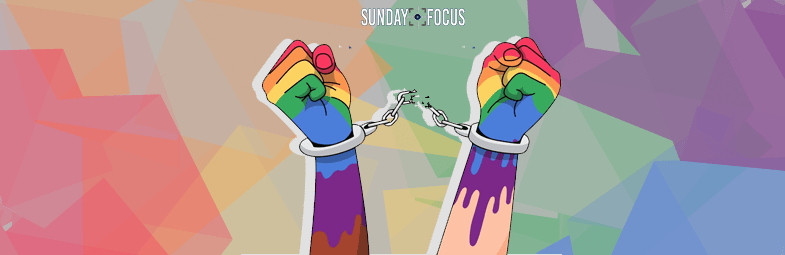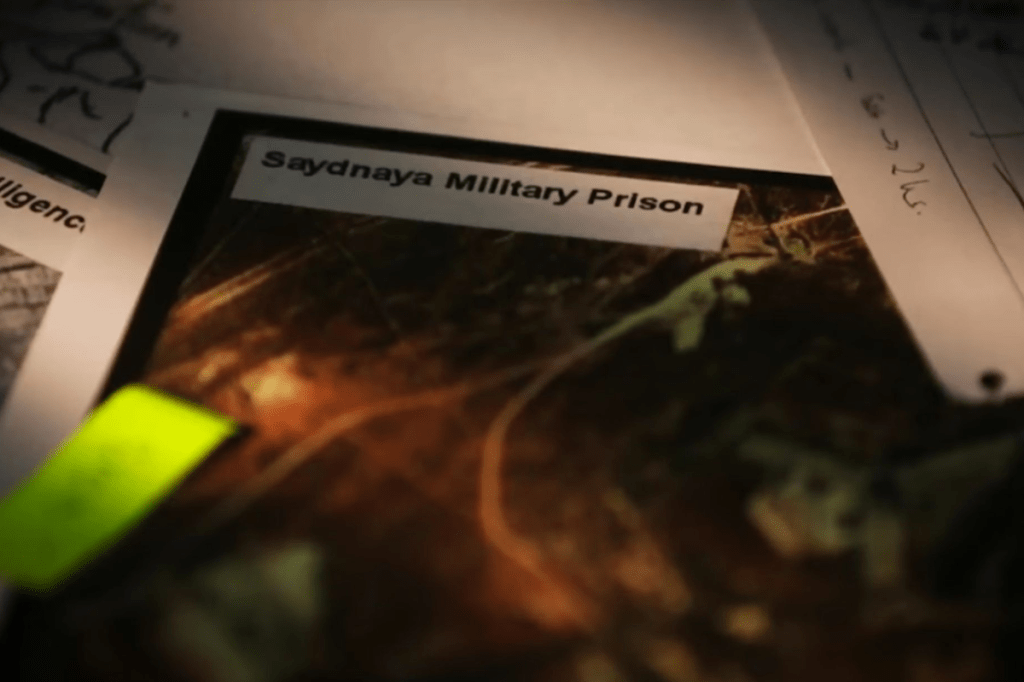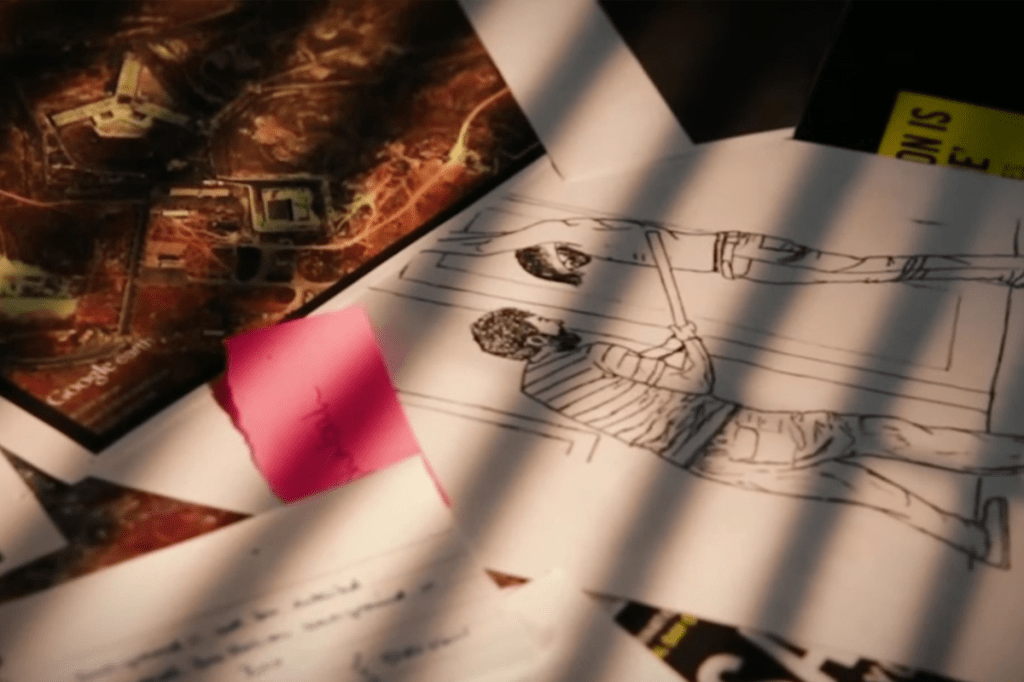A Hong Kong “non è la fine della battaglia”

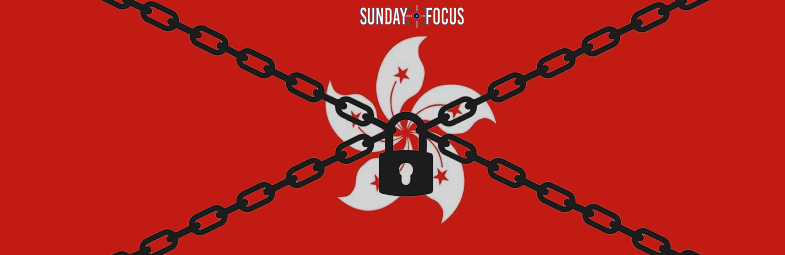
“Hong Kong è il faro della speranza per la democrazia in Cina.
Se questo faro cade e si spegne, la Cina entrerà in un’epoca buia.“
– Dalù; giornalista dissidente cinese –
È già passato un anno da quando ad Hong Kong si consumavano gli ultimi atti delle proteste durate ininterrottamente oltre 8 mesi. Nel 2020, però, l’onda democratica che aveva travolto l’ex colonia britannica stanca delle prepotenze cinesi si è gradualmente interrotta, schiacciata sotto il peso della pandemia e della nuova legge sulla “sicurezza nazionale”.
Legge – Dopo mesi alla finestra a guardare Hong Kong bruciare senza intervenire in modo diretto, la Cina ha infatti deciso di stringere il cappio intorno ai sogni democratici della provincia autonoma. Durante il 13° “National People Congress”, l’assemblea parlamentare cinese che si riunisce annualmente per indicare la rotta politica cinese, è stata infatti annunciata la decisione di elaborare una legge apposita per Hong Kong che mettesse fine alle speranze degli “hongkongers”. Una grave intromissione della Cina negli affari dell’ex colonia che ha di fatto posto fine al modello “un paese due sistemi” sancendo in modo implicito il potere di Pechino su un territorio che avrebbe dovuto godere di una particolare autonomia. La legge, elaborata dai leader del partito comunista cinese, è stata poi approvata dal governo di Hong Kong ed è dunque entrata a pieno titolo nell’ordinamento dell’ex colonia britannica generando effetti devastanti.
La legge, secondo la Cina necessaria per “migliorare il sistema giuridico e i suoi meccanismi di applicazione per salvaguardare la sicurezza nazionale Hong Kong”, ha l’obiettivo dichiarato di prevenire, sopprimere e punire i reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con un paese straniero a danno della stabilità interna con pene che vanno dai tre anni all’ergastolo. Ma l’ampiezza e la vaghezza con cui sono stati definiti tali crimini all’interno del testo, rende di fatto la legge applicabile a discrezione dei giudici in una moltitudine di casi. Giudici e Magistrati che, in occasione dei processi per casi riguardanti la sicurezza nazionale, vengono nominati direttamente da Pechino.
Conseguenze – Come ampiamente previsto, dal momento della sua introduzione la nuova legge è stata ampiamente abusata con il fine di reprimere i movimenti che nei mesi precedenti avevano infiammato la città portando in strada fino a due milioni di persone nelle marce più partecipate di sempre. Nelle settimane immediatamente successive centinaia di persone sono state arrestate anche solo per il possesso di adesivi, volantini, magliette o bandiere con gli slogan delle proteste ritenuti evidentemente pericolosi per la sicurezza di Hong Kong. Lo slogan “Liberate Hong Kong, revolution of our times”, utilizzato durante le proteste, è stato dichiarato sovversivo e messo al bando con divieto assoluto di usarlo o riprodurlo in qualsiasi modo. il controllo sui media è stato intensificato a tal punto che il New York Times ha deciso di chiudere la propria redazione in città spostando la sede asiatica a Seul. Il tutto mentre il governo cinese ha aperto un apposito ufficio con ufficiali mandati da pechino autorizzati ad intervenire per reprimere eventuali tentativi di violare la legge sulla sicurezza nazionale.

A settembre a decine di candidati dei partiti pro-democrazia è stato impedito di partecipare alle elezioni e molti hanno preferito lasciare il paese e chiedere asilo politico tra Taiwan e il Regno Unito. Il magnate della stampa Jimmy Lai, 73enne proprietario del giornale Apple Daily e noto per le sue battaglie pro-democrazia, è stato arrestato ad agosto ed ora rischia l’ergastolo. Il 1° ottobre, in un solo giorno, sono state arrestate 60 persone tra cui due consiglieri distrettuali con l’accusa di aver partecipato ad assemblee non autorizzate. Gli attivisti della rete democratica che hanno deciso di non fuggire, ora rischiano condanne altissime per aver organizzato le manifestazioni dello scorso anno. Tra di oro spiccano i nomi di Joshua Wong, Ivan Lam e Agnes Chow: i tre volti più noti delle manifestazioni antigovernative sono stati condannati rispettivamente a 13, 7 e 10 mesi di detenzione. In un ultimo, sfrontato, atto di sfida al regime cinese si sono consegnati loro alle forze di polizia per farsi arrestare. Davanti ai giudici Wong ha lanciato il suo ultimo messaggio prima di sparire nelle carceri della città: “Pensate di aver vinto” ha detto “ma questa non è la fine della battaglia”.
Prospettive – Ad oggi, certo, risulta difficile crederlo. La Cina sa di avere sufficiente forza per ignorare le proteste, peraltro mai troppo forti, della comunità internazionale e riportare Hong Kong nella propria orbita in modo definitivo spezzando ogni sogno di maggior autonomia. Ha dimostrato di aver imparato dagli errori commessi nel passato e, senza bisogno di alcuno spargimento di sangue come avvenne a Tienanmen nel 1989, ha ripreso il controllo di un territorio popolato da sei milioni di persone che avevano deciso di esprimere la loro insoddisfazione in piazza come alle urne conferendo al fronte democratico una schiacciante vittoria alle elezioni distrettuali dello scorso anno.

Ma allora con che coraggio Wong afferma che la battaglia non è finita? Può farlo perché la storia della città sembra essere dalla sua parte. Hong Kong è sempre riuscita a rialzarsi e a dimostrare che anche quando tutto sembra finito basta poco per trovare la forza per ricominciare. Nel 2014 con la repressione della “rivoluzione degli ombrelli” sembrava fosse finito ogni sogno di cambiamento e invece dopo cinque anni ancora più persone hanno provato a riprendere in mano quei sogni. Anche in quell’occasione Wong aveva avvertito che la battaglia era appena iniziata ed era stato preso per pazzo ma evidentemente non si sbagliava. Perché lui, come gli altri ragazzi che hanno animato le proteste, è un sognatore. Come il condottiero biblico da cui trae il suo nome, Joshua Wong vuole salvare il proprio popolo dall’oppressione cinese e non sembra intenzionato a fermarsi. Sui suoi social utilizza spesso riferimenti alle sacre scritture ed alla cultura popolare per raccontare i trionfi inattesi di personaggi sfavoriti e rilanciare la speranza dei propri concittadini e convincerli a non fermarsi. La voglia di democrazia di Hong Kong non si è fermata sotto la pioggia di lacrimogeni del 2014 ed è tornata cinque anni dopo ad infiammare letteralmente le strade della città con ancora più potenza. E allora sembra quasi logico il ragionamento di Wong: la battaglia non è finita, potete giurarci. Ad Hong Kong il sogno democratico non è spento. E, presto, tornerà a bussare con più forza alle porte di Pechino.