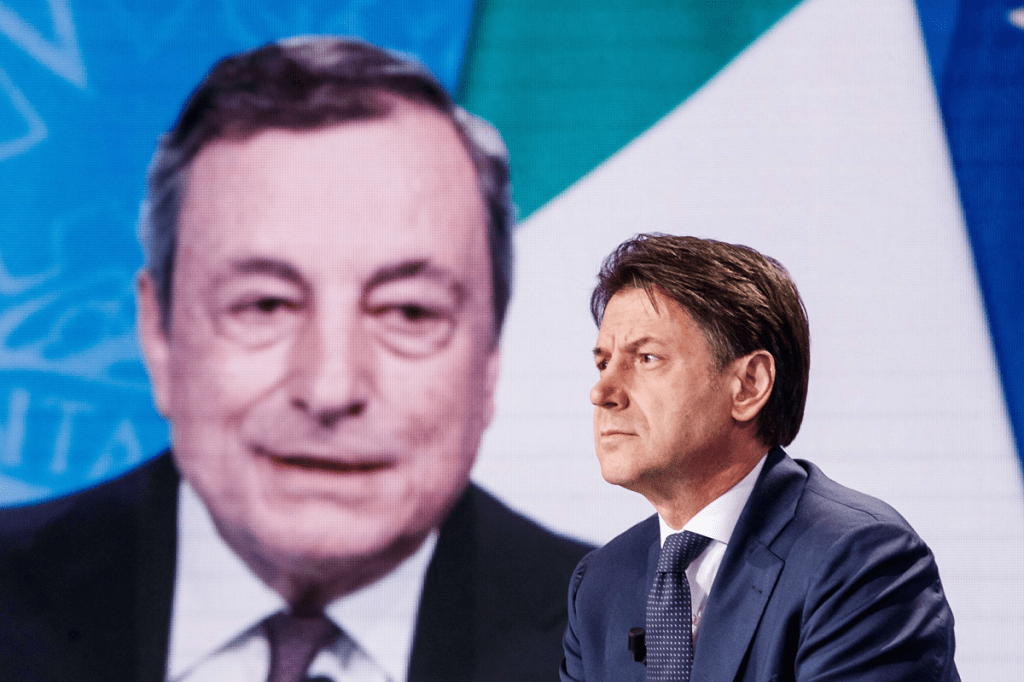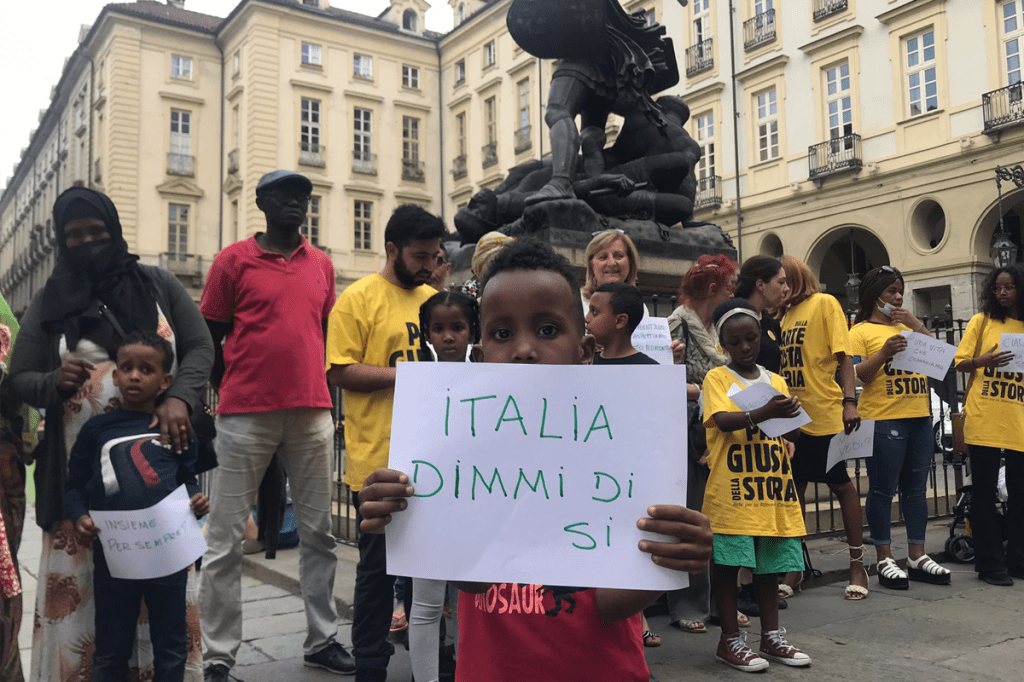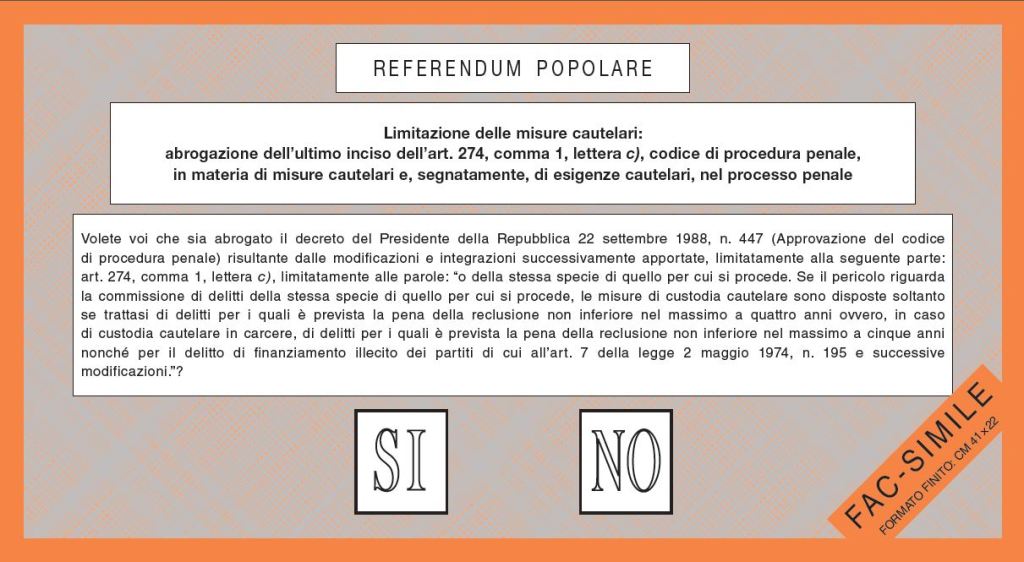Amore e rabbia: l’ultimo discorso pubblico di Paolo Borsellino

A trent’anni dalla strage di via d’Amelio riportiamo il testo integrale dell’ultimo intervento pubblico di Paolo Borsellino alla biblioteca di Casa Professa un mese prima della sua morte.

Sono passati trent’anni da quel 19 luglio 1992 quando un’autobomba davanti alla casa della madre in via Mariano d’Amelio uccise il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina. Erano passati 57 giorni da quando sul tratto di autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi con la città di Palermo era stato ucciso il suo amico e collega Giovanni Falcone. 57 giorni vissuti da Borsellino come “un morto che cammina” con la tremenda consapevolezza che il prossimo a cadere sarebbe stato lui. In quei 57 giorni Borsellino attese con pazienza di essere ascoltato dai magistrati di Caltanissetta che stavano indagando sulla strage di Capaci ma non venne mai chiamato a testimoniare. Eppure era lui quello che più di tutti poteva rivelare i dettagli della vita di Giovanni Falcone. Era lui a conoscerne il lavoro e custodirne i segreti. Borsellino attese paziente per oltre un mese, fino al 25 giugno 1992 quando durante un incontro alla biblioteca comunale di Casa Professa ricordò l’amico e disse chiaramente di voler essere ascoltato. Fu il grido disperato di un uomo che sa di avere poco tempo per ricostruire gli avvenimenti che portarono alla morte di Falcone e fare in modo che quella morte non rimanesse impunita.
Quel grido di dolore rimase inascoltato. Paolo Borsellino non venne mai chiamato dai magistrati di Caltanissetta. Non raccontò mai i segreti che custodiva sul lavoro di Giovanni Falcone. Non gli fu mai permesso di farlo. A trent’anni dalla strage di via d’Amelio riportiamo il testo integrale del discorso di Paolo Borsellino a Casa Professa. Un discorso di amore verso l’amico Falcone e il mentore Antonino Caponnetto. Un discorso di rabbia e tristezza per le condizioni in cui avevano dovuto lavorare.
L’ultimo discorso di Paolo Borsellino – 25 giugno 1992
Io sono venuto questa sera soprattutto per ascoltare. Purtroppo ragioni di lavoro mi hanno costretto ad arrivare in ritardo e forse mi costringeranno ad allontanarmi prima che questa riunione finisca. Sono venuto soprattutto per ascoltare perché ritengo che mai come in questo momento sia necessario che io ricordi a me stesso e ricordi a voi che sono un magistrato. E poiché sono un magistrato devo essere anche cosciente che il mio primo dovere non è quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze partecipando a convegni e dibattiti ma quello di utilizzare le mie opinioni e le mie conoscenze nel mio lavoro. In questo momento inoltre, oltre che magistrato, io sono testimone. Sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni Falcone, avendo raccolto, non voglio dire più di ogni altro, perché non voglio imbarcarmi in questa gara che purtroppo vedo fare in questi giorni per ristabilire chi era più amico di Giovanni Falcone, ma avendo raccolto comunque più o meno di altri, come amico di Giovanni Falcone, tante sue confidenze, prima di parlare in pubblico anche delle opinioni, anche delle convinzioni che io mi sono fatte raccogliendo tali confidenze, questi elementi che io porto dentro di me, debbo per prima cosa assemblarli e riferirli all’autorità giudiziaria, che è l’unica in grado di valutare quanto queste cose che io so possono essere utili alla ricostruzione dell’evento che ha posto fine alla vita di Giovanni Falcone, e che soprattutto, nell’immediatezza di questa tragedia, ha fatto pensare a me, e non soltanto a me, che era finita una parte della mia e della nostra vita.
Quindi io questa sera debbo astenermi rigidamente – e mi dispiace, se deluderò qualcuno di voi – dal riferire circostanze che probabilmente molti di voi si aspettano che io riferisca, a cominciare da quelle che in questi giorni sono arrivate sui giornali e che riguardano i cosiddetti diari di Giovanni Falcone. Per prima cosa ne parlerò all’autorità giudiziaria, poi – se è il caso – ne parlerò in pubblico. Posso dire soltanto, e qui mi fermo affrontando l’argomento, e per evitare che si possano anche su questo punto innestare speculazioni fuorvianti, che questi appunti che sono stati pubblicati dalla stampa, sul “Sole 24 Ore” dalla giornalista – in questo momento non mi ricordo come si chiama… – Milella, li avevo letti in vita di Giovanni Falcone. Sono proprio appunti di Giovanni Falcone, perché non vorrei che su questo un giorno potessero essere avanzati dei dubbi.
Ho letto giorni fa, ho ascoltato alla televisione – in questo momento i miei ricordi non sono precisi – un’affermazione di Antonino Caponnetto secondo cui Giovanni Falcone cominciò a morire nel gennaio del 1988. Io condivido questa affermazione di Caponnetto. Con questo non intendo dire che so il perché dell’evento criminoso avvenuto a fine maggio, per quanto io possa sapere qualche elemento che possa aiutare a ricostruirlo, e come ho detto ne riferirò all’autorità giudiziaria; non voglio dire che cominciò a morire nel gennaio del 1988 e che questo, questa strage del 1992, sia il naturale epilogo di questo processo di morte. Però quello che ha detto Antonino Caponnetto è vero, perché oggi che tutti ci rendiamo conto di quale è stata la statura di quest’uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il paese, lo Stato, la magistratura che forse ha più colpe di ogni altro, cominciò proprio a farlo morire il 1° gennaio del 1988, se non forse l’anno prima, in quella data che ha or ora ricordato Leoluca Orlando: cioè quell’articolo di Leonardo Sciascia sul “Corriere della Sera” che bollava me come un professionista dell’antimafia, l’amico Orlando come professionista della politica, dell’antimafia nella politica. Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, il Consiglio superiore della magistratura con motivazioni risibili gli preferì il consigliere Antonino Meli. C’eravamo tutti resi conto che c’era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi due anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest’uomo, Caponnetto, il quale rischiava, perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva. E a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pure estremamente convinti del pericolo che si correva così convincendolo, lo convincemmo riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all’ufficio istruzione al tribunale di Palermo. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro, e il giorno del mio compleanno il Consiglio superiore della magistratura ci fece questo regalo: preferì Antonino Meli.
Giovanni Falcone, dimostrando l’altissimo senso delle istituzioni che egli aveva e la sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e nel quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio superiore della magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall’esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d’Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento che venne subito commentato da Leoluca Orlando, allora presente, dicendo che quella sera l’aria ci stava pesando addosso per quello che era stato detto. Leoluca Orlando ha ricordato cosa avvenne subito dopo: per aver denunciato questa verità io rischiai conseguenze professionali gravissime, ma quel che è peggio il Consiglio superiore immediatamente scoprì quale era il suo vero obiettivo: proprio approfittando del problema che io avevo sollevato, doveva essere eliminato al più presto Giovanni Falcone. E forse questo io lo avevo pure messo nel conto perché ero convinto che lo avrebbero eliminato comunque; almeno, dissi, se deve essere eliminato, l’opinione pubblica lo deve sapere, lo deve conoscere, il pool antimafia deve morire davanti a tutti, non deve morire in silenzio.
L’opinione pubblica fece il miracolo, perché ricordo quella caldissima estate dell’agosto 1988, l’opinione pubblica si mobilitò e costrinse il Consiglio superiore della magistratura a rimangiarsi in parte la sua precedente decisione dei primi di agosto, tant’è che il 15 settembre, se pur zoppicante, il pool antimafia fu rimesso in piedi. La protervia del consigliere istruttore, l’intervento nefasto della Cassazione cominciato allora e continuato fino a ieri (perché, nonostante quello che è successo in Sicilia, la Corte di cassazione continua sostanzialmente ad affermare che la mafia non esiste) continuarono a fare morire Giovanni Falcone. E Giovanni Falcone, uomo che sentì sempre di essere uomo delle istituzioni, con un profondissimo senso dello Stato, nonostante questo, continuò incessantemente a lavorare. Approdò alla procura della Repubblica di Palermo dove, a un certo punto ritenne, e le motivazioni le riservo a quella parte di espressione delle mie convinzioni che deve in questo momento essere indirizzata verso altri ascoltatori, ritenne a un certo momento di non poter più continuare ad operare al meglio. Giovanni Falcone è andato al ministero di Grazia e Giustizia, e questo lo posso dire sì prima di essere ascoltato dal giudice, non perché aspirasse a trovarsi a Roma in un posto privilegiato, non perché si era innamorato dei socialisti, non perché si era innamorato di Claudio Martelli, ma perché a un certo punto della sua vita ritenne, da uomo delle istituzioni, di poter continuare a svolgere a Roma un ruolo importante e nelle sue convinzioni decisivo, con riferimento alla lotta alla criminalità mafiosa. Dopo aver appreso dalla radio della sua nomina a Roma (in quei tempi ci vedevamo un po’ più raramente perché io ero molto impegnato professionalmente a Marsala e venivo raramente a Palermo), una volta Giovanni Falcone alla presenza del collega Leonardo Guarnotta e di Ayala tirò fuori, non so come si chiama, l’ordinamento interno del ministero di Grazia e Giustizia, e scorrendo i singoli punti di non so quale articolo di questo ordinamento cominciò fin da allora, fin dal primo giorno, cominciò ad illustrare quel che lì egli poteva fare e che riteneva di poter fare per la lotta alla criminalità mafiosa.
Certo anch’io talvolta ho assistito con un certo disagio a quella che è la vita, o alcune manifestazioni della vita e dell’attività di un magistrato improvvisamente sbalzato in una struttura gerarchica diversa da quelle che sono le strutture, anch’esse gerarchiche ma in altro senso, previste dall’ordinamento giudiziario. Si trattava di un lavoro nuovo, di una situazione nuova, di vicinanze nuove, ma Giovanni Falcone è andato lì solo per questo. Con la mente a Palermo, perché sin dal primo momento mi illustrò quello che riteneva di poter e di voler fare lui per Palermo. E in fin dei conti, se vogliamo fare un bilancio di questa sua permanenza al ministero di Grazia e Giustizia, il bilancio anche se contestato, anche se criticato, è un bilancio che riguarda soprattutto la creazione di strutture che, a torto o a ragione, lui pensava che potessero funzionare specialmente con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al lavoro che aveva fatto a Palermo. Cercò di ricreare in campo nazionale e con leggi dello Stato quelle esperienze del pool antimafia che erano nate artigianalmente senza che la legge le prevedesse e senza che la legge, anche nei momenti di maggiore successo, le sostenesse. Questo, a torto o a ragione, ma comunque sicuramente nei suoi intenti, era la superprocura, sulla quale anch’io ho espresso nell’immediatezza delle perplessità, firmando la lettera sostanzialmente critica sulla superprocura predisposta dal collega Marcello Maddalena, ma mai neanche un istante ho dubitato che questo strumento sulla cui creazione Giovanni Falcone aveva lavorato servisse nei suoi intenti, nelle sue idee, a torto o a ragione, per ritornare, soprattutto, per consentirgli di ritornare a fare il magistrato, come egli voleva. Il suo intento era questo e l’organizzazione mafiosa – non voglio esprimere opinioni circa il fatto se si è trattato di mafia e soltanto di mafia, ma di mafia si è trattato comunque – e l’organizzazione mafiosa, quando ha preparato ed attuato l’attentato del 23 maggio, l’ha preparato ed attuato proprio nel momento in cui, a mio parere, si erano concretizzate tutte le condizioni perché Giovanni Falcone, nonostante la violenta opposizione di buona parte del Consiglio superiore della magistratura, era ormai a un passo, secondo le notizie che io conoscevo, che gli avevo comunicato e che egli sapeva e che ritengo fossero conosciute anche al di fuori del Consiglio, al di fuori del Palazzo, dico, era ormai a un passo dal diventare il direttore nazionale antimafia.
Ecco perché, forse, ripensandoci, quando Caponnetto dice cominciò a morire nel gennaio del 1988 aveva proprio ragione anche con riferimento all’esito di questa lotta che egli fece soprattutto per potere continuare a lavorare. Poi possono essere avanzate tutte le critiche, se avanzate in buona fede e se avanzate riconoscendo questo intento di Giovanni Falcone, si può anche dire che si prestò alla creazione di uno strumento che poteva mettere in pericolo l’indipendenza della magistratura, si può anche dire che per creare questo strumento egli si avvicinò troppo al potere politico, ma quello che non si può contestare è che Giovanni Falcone in questa sua breve, brevissima esperienza ministeriale lavorò soprattutto per potere al più presto tornare a fare il magistrato. Ed è questo che gli è stato impedito, perché è questo che faceva paura.
E per questo, crediamo, Giovanni Falcone è morto.